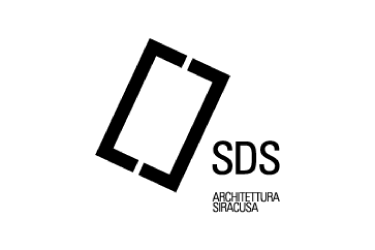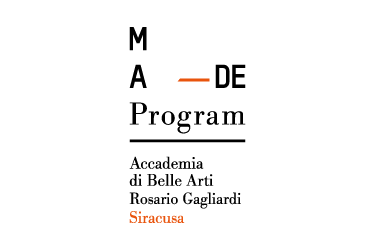Descrizione
All'interno è presente il sacrario dei caduti della I e II guerra mondiale. Con pianta a croce latina, è considerata una tra le chiese più grandi della Sicilia. All'esterno è incompiuta con 4 coppie di colonne mozze e il prospetto.
Il monastero appare diviso dal resto della città, ed è costituita da un alto muro di cinta su cui si aprono i due portali principali: il primo a nord è situato in fondo alla via Gesualdo Clementi, il secondo, affacciato su piazza Dante, in corrispondenza dell'antico monastero cinquecentesco. Da questo secondo portale si accede all'enorme corte esterna che ha funzioni di filtro tra il mondo esterno laico e quello religioso dell'edificio.
Circondato da un grande cortile, sorge il monastero vero e proprio, celebrato da Patrick Brydone nel 1773, che lo definì la “Versailles siciliana”. Un'infinita serie di volute, fiori, frutti, mascheroni mostruosi, putti, e ninfe adornano le mostre delle finestre e i balconi, mentre le paraste giganti a punta di diamante e coronate da capitelli corinzi, denunciano la loro natura ornamentale nel cornicione sovrastante che non vi poggia direttamente a causa di una frangia decorativa fatta di volute e conchiglie che sembra pendere dal cornicione. Al centro della facciata principale, ad interrompere la sua sfarzosa teatralità barocca, troviamo il maestoso portale nella sua semplice linearità.
La struttura interna dell'edificio appare estremamente simmetrica con i due vasti chiostri quadrati, sui cui lati corrono lunghi corridoi che si intersecano e su cui si aprono le porte delle celle dei monaci, dei frati, dell'appartamento dell'abate e di quello del re.
Riferimenti storici
Gli edifici monastici di San Nicolò l'Arena occupano un'area enorme, che cinge su tre lati la grande chiesa.
La chiesa venne costruita su progetto dell'architetto romano Giovanni Battista Contini a partire dal 1687 e conserva il grande organo barocco di Donato Del Piano.